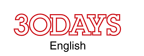La religione della luce: la salvezza attraverso la gnosi
«Da quasi venti secoli dall’apparizione del cristianesimo, il manicheismo è certamente quanto di più meraviglioso s’è prodotto nel globo terrestre nella storia spirituale dell’umanità». Questa affermazione di Simone Weil consente di comprendere l’attrattiva che esercita ancor oggi la posizione manichea, che più di altre presume di interpretare la condizione dell’uomo decaduto unitamente al suo desiderio di salvezza
di Massimo Borghesi

A sinistra e nella pagina seguente, particolari della tavola L'ascesa all'Empireo, parte del trittico Visioni dell'Aldilà, 1500-1504, Hieronymus Bosch, Palazzo Ducale, Venezia
A sinistra e nella pagina seguente, particolari della tavola L'ascesa all'Empireo, parte del trittico Visioni dell'Aldilà, 1500-1504, Hieronymus Bosch, Palazzo Ducale, Venezia

A sinistra e nella pagina seguente, particolari della tavola L'ascesa all'Empireo, parte del trittico Visioni dell'Aldilà, 1500-1504, Hieronymus Bosch, Palazzo Ducale, Venezia
A sinistra e nella pagina seguente, particolari della tavola L'ascesa all'Empireo, parte del trittico Visioni dell'Aldilà, 1500-1504, Hieronymus Bosch, Palazzo Ducale, Venezia
"Da quasi venti secoli dall’apparizione del cristianesimo, il manicheismo è certamente quanto di più meraviglioso s’è prodotto nel globo terrestre nella storia spirituale dell’umanità"1.
L’affermazione, di Simone Weil, consente di comprendere l’attrattiva che esercita ancor oggi una posizione, come quella manichea, che più di altre presume di interpretare la condizione dell’uomo decaduto unitamente al suo desiderio di salvezza. Nel suo pessimismo cosmico il manicheismo, come acutamente mostra Hans Jonas nei suoi studi sullo gnosticismo2, mostra affinità sorprendenti con il nichilismo contemporaneo. Prigioniera di un mondo perverso, contrassegnato dal caos e dalla distruzione, l’anima anela a fuggire il carcere corporeo per ritrovare la patria perduta, il regno divino di luce opposto alle tenebre della materia, da cui originariamente proviene. L’uomo è uno "straniero" nel mondo, un "dio esiliato" dominato dai sentimenti della rivolta e del disgusto verso l’esistenza presente, dalla nostalgia di ciò che è stato, verso il paradiso perduto che la gnosi gli farà riconquistare. Come recita un frammento antico: "Nato dalla Luce e dagli dei, / eccomi in esilio e separato da loro. / I nemici, lanciandosi su di me / mi hanno trasportato tra i morti. / Che sia benedetto e trovi liberazione / colui che libererà la mia anima dall’angoscia! / Sono un dio e nato dagli dei, / brillante, scintillante, luminoso, / raggiante, profumato e bello, / ma ora ridotto a soffrire"3.
Il dio "perduto", l’anima di luce, si trova incatenato alla materia, ridotto alla condizione servile; uomo dei dolori è "crocifisso" nella terra opera delle potenze demoniche. È lo Iesus Patibilis della tradizione manichea.
L’uomo soffre perché la sua anima, la parte divina che è in lui, è "mescolata" alla materia la quale, nel manicheismo come nello gnosticismo, è il male. "La Materia ha fatto il primo uomo cieco e sordo, incosciente e smarrito, a tal punto che non conosce né la sua origine, né la sua schiatta [la sua famiglia divina]. Essa ha creato il corpo e la prigione; essa ha incatenato l’anima che ha perduto la conoscenza. – Orribili sono per me, prigioniero, i demoni, le diavolesse e tutte le streghe! – Az [la Concupiscenza, la materia] ha legato saldamente l’anima al corpo maledetto. L’ha fatta orribile e malvagia, piena di collera e avida di vendetta"4. L’esistenza mortale è un aborto. Nella mitologia manichea essa è il frutto di una progenie perversa creata non da Dio ma da una coppia di demoni i quali, dopo aver divorato i loro figli, si accoppiano e danno vita alla prima coppia di uomini: Adamo ed Eva. All’origine della specie umana v’è il duplice sigillo dell’eredità satanica fatto di cannibalismo e sessualità. Un sigillo che si perpetua con l’atto di procreazione, con la generazione dei viventi attraverso la quale il mondo, il carcere oscuro, continua. Continua ad incatenare le anime, ad imprigionare la "luce". "Se ne deduce che il peccato è anzitutto il risultato dell’inerenza dell’anima alla "mescolanza": L’esistenza – potremmo dire – è peccato di per se stessa. L’anima non è di per sé peccatrice e in fondo non è responsabile del peccato: non soccombe ad esso per propria volontà, ma vi è indotta dalla mescolanza con la carne […]. La sola causa del peccato è la materia, la cui essenza è costituita dal male e la cui espressione naturale, spontanea, è la "concupiscenza""5.
A partire da questa duplice affermazione – l’anima è innocente, la materia è il male – il manicheismo si configura, nel suo essere "religione di salvezza", come un’altra strada rispetto a quella affermata dal cristianesimo. L’esistenza non diventa malvagia con il consenso della libertà ma lo è in se stessa. Malvagità che può essere espiata solo con la purificazione dai corpi e con un cammino, più o meno tortuoso, di trasmigrazione delle anime di corpo in corpo dalla cui catena solo gli Eletti, i "Puri", sono definitivamente sciolti. Una prospettiva, questa, che si incontra con la tradizione buddhistica, per la quale la redenzione risiede in una sorta di de-creazione, di nullificazione, di distacco, di astrazione. Se il male risiede nella "commistione" dell’anima con il corpo, della luce con la materia, la salvezza sarà data dalla divisione, dalla sottrazione dell’una dall’altra. Salvarsi è separarsi. La morale manichea è una morale negativa. "Essa invero implica un rifiuto, un rigetto e come una negazione del mondo che ci opprime, degli esseri malvagi che lo dominano, che è la condizione di schiavitù e per tali aspetti può essere accostata all’atteggiamento di rivolta, o addirittura di nichilismo, che si riscontra al fondo di più d’un sistema gnostico"6.
Un cristianesimo gnostico-zoroastriano
Come si forma la "visione del mondo" manichea, la visione di Mani che ne è il fondatore? Rispondere a questa domanda, che ha fatto versare fiumi d’inchiostro, è oggi ragionevolmente possibile nella misura in cui il cosidetto Codice manicheo di Colonia, scoperto nel 1969 in Egitto, ci offre una biografia attendibile di Mani risalente forse al V secolo. Mani, nato nel 216 d.C. in una località della Babilonia settentrionale, iniziò, a partire dal 240, la sua predicazione che lo porterà in India e, al suo ritorno, alla corte del re dei Persiani Sabuhr I (240-272), il sovrano che umiliò ben tre imperatori romani (Gordiano III, Filippo l’Arabo, Valeriano), e dal quale Mani ottenne consenso e protezione. Grazie a ciò la "Chiesa" manichea poté svilupparsi e diffondersi. Mani inviò missionari in Siria, Egitto, Battriana, Armenia, Palmira. "Ma quanto alla mia speranza", affermerà, "essa andrà verso Occidente e andrà pure verso Oriente. E si udirà la voce del suo messaggio in tutte le lingue, e lo si annuncerà in tutte le città. La mia Chiesa è superiore su questo punto alle Chiese precedenti, poiché queste Chiese precedenti erano elette in paesi singoli e in singole città. Ma quanto alla mia Chiesa, essa si diffonderà in tutte le città, e il mio Vangelo raggiungerà ogni paese"7.
Un "Vangelo" universale quello di Mani che porterà l’autore, in un destino paragonato dai suoi discepoli a quello di Cristo, alla ostilità dei sacerdoti zoroastriani e alla prigionia ad opera del re Wahram I (273-277). Sotto il peso delle catene morirà, nel 277, all’età di sessant’anni. Grazie al Codice di Colonia, di cui è disponibile ora, dopo quella inglese, una traduzione italiana (parziale) nel volume Il manicheismo edito dalla Fondazione Lorenzo Valla8, siamo in grado di penetrare nella formazione di Mani, quel periodo dai quattro ai ventiquattro anni da lui trascorso presso una comunità di Battisti giudeo-cristiani che si rifacevano all’insegnamento di un maestro di nome Elchasai. La scoperta dell’inserimento di Mani in questo ambiente è di grande importanza perché, come scrive la Sfameni Gasparro, "ha contribuito in maniera decisiva ad orientare la ricerca sulla dimensione giudeo-cristiana del fenomeno manicheo nel suo complesso"9. Il Mani-Codex dell’Università di Colonia ridimensiona cioè gli altri filoni interpretativi sulla genesi del manicheismo – quelli "orientali" buddhistico-iranici (F.C. Baur, R. Reitzenstein) – i quali mantengono la loro validità ma solo in via subordinata. Esso, e non è una conseguenza marginale, restituisce piena validità alla testimonianza di Agostino sul manicheismo dopo che questa, a partire dal lavoro di Isaac de Beausobre, Histoire critique de Manichée et du Manichéisme (Amsterdam 1734-1739), era stata decisamente contestata10.
Consente, inoltre, di comprendere quell’affermazione, a prima vista sorprendente: "Io, Mani, apostolo di Gesù Cristo"11, così come le numerose altre in cui Mani si dichiara manifestazione del Paraclito, sino al punto da identificarsi con lo Spirito di Verità e, quindi, con la pienezza della Rivelazione. Affermazioni che non sorgono semplicemente, come si è spesso affermato in passato, dal disegno di adattamento ad ambienti cristiani, quanto piuttosto dalla trasposizione della dottrina cristiana in un registro manifestamente gnostico. Come osserva A. Böhlig: "Nella sua giovinezza e per il tramite dei suoi predecessori Mani naturalmente ha avuto modo di conoscere varie correnti religiose; giudeo-cristianesimo di marca gnostica era l’ambiente della sua fanciulleza; idee iraniche possono essere state trasmesse a lui in virtù della sua discendenza. Il mondo del buddhismo fu da lui incontrato nell’est dell’Iran e in India, durante i suoi viaggi. Forse il suo dualismo radicale fu influenzato da idee iraniche […]. Tuttavia la tendenza basilare del mito, che esprime la spinta centrale della sua credenza, è […] un cristianesimo gnostico che rappresenta in ampia prospettiva il cammino del Figlio di Dio variamente incarnato come creatore e redentore, al fine di essere, mediante la sua gnosi e le conseguenze che ne derivano, presentato al Padre"12.
Nasce così il manicheismo. Nasce come religione della "separazione", come conoscenza (gnosi) della salvezza attraverso la distinzione tra il puro e l’impuro. Due dogmi sono al centro della cosmo-teologia manichea: quello dei "Due Principî" e quello dei "Tre Tempi". Per il primo, Bene e Male, la Luce e le Tenebre, lo Spirito e la Materia, sono due Sostanze antagoniste e irriducibili. Un dualismo che rivela l’eco dello zoroastrismo ma anche, probabilmente, di Marcione. Per il secondo dogma il dualismo tra i due Principî vale all’inizio e alla fine del mondo ma non durante il periodo "mediano" in cui essi s’intrecciano in una mescolanza che dà luogo alla condizione presente dell’esistenza. Il nostro mondo è "Mescolanza", mistura di bene e di male secondo un legame che "incatena" l’anima al corpo e le impedisce la memoria delle sue origini divine. Questa "caduta" dell’anima nel mondo non è che un momento di quella lotta cosmica tra il Regno della Luce e il Regno dellahh Materia che vede all’inizio l’"Uomo Primevo", personificazione del Padre, cadere in pasto dei demoni che ne divorano l’anima. La Materia inghiotte in tal modo una parte dell’anima divina: è l’Anima del mondo che, trattenuta ovunque – nelle piante, negli animali, nel corpo umano – geme della sua prigionia anelando il ritorno al Regno di Luce. Se così è, il manicheismo può apparire come "religione di salvezza" nella misura in cui, liberando l’anima dai suoi lacci, consente il ritorno alla dualità originaria, all’assoluta separazione tra i due mondi. La salvezza è ""rigenerazione", "rinascita", nel senso che consiste, per lo Spirituale, nel "raccogliere" (syllegein) la propria sostanza luminosa e divina, nel recuperare il suo vero io, nel tornare al suo essere e al luogo primitivo"15. La salvezza è nella "raccolta" della sostanza luminosa celata e sepolta nel corpo del mondo, nella "restaurazione" del divino disperso, dis-unito, nel ritorno alla dualità originaria. In questa salvezza anche Gesù, il "Nous divino", svolge un suo ruolo. Un ruolo che Mani, "apostolo di Gesù Cristo", si propone di portare a compimento.
Il Salvatore-salvato.
Salvezza dell’anima e salvezza di Dio
Come per Ugo Bianchi16 anche per Henri Charles Puech "il manicheismo è una religione del Nous"17. Il problema della salvezza si risolve, cioè, nel problema della conoscenza, nel richiamo che l’intelletto (Nous) opera verso l’anima (psykhe) dormiente, avviluppata nel sonno della materia. Questa conoscenza, anamnesi, reminiscenza delle proprie origini, ricordo della patria divina, richiede, per essere messa in atto, un messaggio, un divino messaggero che incarna, di volta in volta, la potenza della Luce. È in questa prospettiva che il manicheismo postula una catena di "Salvatori", di divini inviati che ridestano l’anima dal sonno, che invitano l’umanità alla separazione, alla fuga dal mondo, al rifiuto dei demoni e del commercio con i cibi e la procreazione. Questa catena di "Fiaccole", "Luminari", "Illuminatori", che va da Adamo, Seth, Eno, Henoch, Nicoteo, Noè, Sem, Abramo, a Buddha, Zoroastro, Gesù, Mani, rappresenta, in realtà, un unico eroe. "I personaggi dai nomi multipli che interverranno nella cosmogonia e nella soteriologia non saranno in fondo, per la maggior parte, che le incarnazioni o le espressioni successive di questa stessa Entità o le funzioni ipostatizzate dell’attività divina"18.
Questa "Attività", in un processo circolare che ricorda da vicino quello hegeliano, "salvando" le scintille di luce disperse nella materia, salva anche se stessa. "È una sola e medesima sostanza – la Luce, che è Dio stesso – che è mescolata a una Materia trasformata in mondo e in corpo, e per conseguenza sarà un’operazione identica quella intesa a liberare dall’universo e a salvare nell’organismo umano questa sostanza luminosa. Insomma, dappertutto e sempre è Dio stesso che, in parte, è inghiottito nelle Tenebre e se ne libera; è una stessa Entità che, sul piano cosmologico e antropologico, è a un tempo l’essere da salvare e l’essere che salva. Ritroviamo qui […] la figura che Reitzenstein intendeva scoprire al centro di ogni gnosticismo: il "Salvatore-Salvato""19.
L’Entità mitica dei manichei, il Dio della Luce, si salva nella misura in cui gli uomini "pneumatici" sono salvati. "Gli "Spirituali", infatti, rappresentano l’insieme della sostanza luminosa decaduta e sparsa nella materia, e il recupero del loro vero io corrisponde, in pari tempo, alla "riunione" progressiva delle "particelle" di tale sostanza, delle "membra" di quel personaggio divino che, raggruppate in tal modo, fanno ritorno a poco a poco all’unità, al tutto organico che formavano all’origine. Salvando gli "pneumatici" l’eroe mitico salva se stesso, allo stesso modo che gli "pneumatici", salvando se stessi, contribuiscono alla salvezza di quell’essere di cui fanno parte per essenza. In fin dei conti, e secondo tale impostazione, il dramma gnostico della salvezza potrebbe ridursi a un tema unico: quello del "Salvatore-Salvato", l’essere divino la cui storia va da un decadimento a un salvamento, potendo assumere in qualche momento la figura dell’Anthropos, dell’Uomo di cui gli uomini rappresentano il frazionamento"20.
Lungo la storia dell’Anthropos, dell’Uomo Primevo che rinasce attraverso la riunificazione delle scintille di luce, troviamo anche Gesù Cristo. Mani, "apostolo di Gesù Cristo", che in quanto Spirito Santo è il compimento della Rivelazione del Nous, intende Gesù come il Salvatore che illumina, che desta l’anima dal sonno, come un momento del "Salvatore-Salvato". È il crocifisso che risveglia l’anima crocifissa e mescolata al corpo. Per questo "la sua Passione non ha valore salvifico che in quanto insegnamento fruttuoso per l’intelligenza umana, e non tanto per il suo carattere di sacrificio quanto come esempio. Per il manicheismo, infatti, essa è puramente apparente. Se Gesù fosse nato da donna, se il suo corpo fosse stato identico al nostro, quel dio avrebbe partecipato alla corruttibilità; alla sozzura della carne, ovvero quest’ultima sarebbe stata esente dal peccato, il che, da un punto di vista dualista, non può che essere contraddittorio. La realtà delle sofferenze patite sulla croce toglierebbe alla Passione qualsiasi carattere divino: come nella gnosi docetista, è al contrario perché Gesù è rimasto "impassibile" che ha insegnato all’anima la separazione assoluta che essa deve porre fra il corpo e il nous. Per giunta, la passione di Cristo non è che un’illustrazione della crocifissione cosmica subita, secondo il mito, dallo Iesus Patibilis: essa è un atto storico che esprime, in forma avvincente, la dottrina del "Salvatore-Salvato". Come scrive Alessandro di Licopoli, "alla fine il Nous [che è Gesù] mediante la sua crocifissione ha fatto conoscere che è in modo simile che anche la potenza divina è fissata, crocifissa alla materia". Non sarà dunque, come per il cristiano, nella partecipazione a Gesù incarnato e crocifisso che il manicheo ritroverà la sua salvezza, bensì grazie all’insegnamento e all’esempio di un Gesù che ha rivestito un’apparenza fisica soltanto per manifestarsi al mondo nel tempo e la cui missione è stata, anzitutto, di svegliare e illuminare le anime"21.
La Passione di Gesù è un esempio per tutti, è la manifestazione della "Luce crocifissa e mescolata alla materia, in una passione cosmica e intemporale"22. La Passione di Gesù è la passione dell’anima incatenata alla materia. L’Anima del mondo, "questa parte consustanziale di Dio, mescolata in tutti i corpi, e curiosamente collegata alle erbe, ai semi, ai tronchi e ai frutti degli alberi, questa "Anima Vivente" viene spesso assimilata, con un simbolo grandioso, al personaggio dello Iesus Patibilis. Essa è il volto "patetico" del Gesù trascendente, la parte dolorosa e da salvare di Yso ziwa, Salvatore in quanto pura luce. Questo Gesù cosmico e intemporale è crocifisso sulla materia con cui la sua anima luminosa è "mescolata". Il mondo intero è la "Croce della luce". Saranno più particolarmente gli alberi, in cui si trova concentrata una larga parte della sostanza divina, a servire da forche al Cristo: secondo l’espressione del manicheo Fausto riportata da sant’Agostino, "Gesù, la Vita e la Salvezza degli uomini, è appeso a qualsiasi legno (patibilis Iesus, suspensus ex ligno)". La Passione e la Crocifissione del Gesù storico si allargano alle proporzioni di eventi universali ed eterni e propongono una lezione esemplare. "Noi vediamo dappertutto", dice Fausto, "la fissione mistica di Gesù alla sua croce (crucis eius mystica fixio)". Per mezzo di essa sono manifestate le ferite della passione che soffre l’anima nostra"23.
Allo stesso modo che in Hegel la kenosi del Logos diventa il simbolo di un processo universale: quello dell’anima "crocifissa" alla materia che anela il ritorno al Padre. "Il divenire universale è così lo svolgimento della passione di un Dio che è il Salvatore di se stesso, e la storia dell’umanità si confonde con il dramma della nostra passione e della nostra salvezza consustanzialmente legati a quell’essere mitico e a quel mitico processo"24.
Il patire divino è il nostro patire poiché la nostra anima, la scintilla di luce, è parte dell’Uomo Primevo, del dio smembrato, dissolto in miriadi di frammenti e "sepolto" nella materia. La nostra anima è "un frammento, una particella, è un "membro", una porzione organica, sostanziale, di Dio. Ancora più precisamente, l’anima umana, in quanto passiva e mescolata alle Tenebre, fa tutt’uno con la dynamis pathetike del Salvatore, collo Iesus Patibilis, di cui ripete o prolunga la crocifissione cosmica"25.


Posterità manichea
La religione di Mani non conclude la sua storia nell’arco dei primi secoli dell’era cristiana. Essa avrà, al contrario, una sua posterità. Questo "Ideale di morte"28, fondato sull’inazione, sul disprezzo per l’agricoltura – che sottopone a tortura le membra di Dio –, per il matrimonio e la procreazione, per l’intero mondo fisico, la cui radicalizzazione comporta l’annientamento dell’umanità e del mondo, continuerà, per rivoli sotterranei, ad infiammare l’immaginario religioso. La ritroviamo attuale, anche se non siamo in grado di tracciarne l’albero genealogico, nelle grandi eresie del Medioevo. Nel Paulicianesimo, sorto nell’Armenia del VII secolo; nel Bogomilismo, sorto nella Bulgaria del X secolo e poi irradiatosi nei Balcani, in Asia Minore e in Russia; nei Catari, nella Francia del XII secolo. In tutti è presente il dualismo dei Principî, la suddivisione tra "Perfetti" e "Credenti", la condanna della carne e del sesso. L’"eresia del male" si oppone, in tal modo, alla visione cristiana del peccato originale, si oppone, in un nichilismo radicale, alla creazione considerata opera di Satana. Un pessimismo cupo, questo, che tornerà vivo in alcune correnti della Riforma e che porterà non a caso il calvinista Pierre Bayle a rivalutare, nel suo Dictionnaire historique et critique del 1697, il manicheismo come l’unica alternativa razionale al cristianesimo nella spiegazione del problema del male. Posizione destinata a incontrare più di un consenso nell’ambito della modernità, a partire dalla temperie romantica, così come l’esempio di Simone Weil, grande estimatrice dei Catari, documenta. Posizione che, anche se la cosa è trascurata dalla critica e dagli stessi studiosi del fenomeno manicheo, si ritrova, in forme sorprendentemente analoghe, nella Qabbalah di Yitzhak Luria (1534-1572) che tanta influenza avrà nel pensiero ebraico, e non solo ebraico, moderno. L’idea luriana della "rottura dei vasi" e del tiqqùn ricordano molto da vicino la posizione manichea. La rottura dei vasi, collocata all’inizio del processo cosmico, richiama il mito della caduta delle "scintille di luce" nella materia, della "mescolanza" tra il puro e l’impuro, così come il tiqqùn quello della "raccolta" della sostanza luminosa. "Tutto è in esilio. La luce spirituale della Shekhinà piomba nell’oscurità del mondo demoniaco del male. Ne risulta il mescolarsi del bene e del male, che dovranno essere separati di nuovo con la riassunzione degli elementi della luce e col loro ritorno alla posizione precedente"29. Come osserva Gershom Scholem: "Si rivela qui una strana affinità con le idee religiose fondamentali dei manichei: un’affinità la cui evidenza non può sfuggire allo storico delle religioni. Elementi della gnosi – assenti o trascurabili nell’antica Qabbalah – e specialmente la teoria delle scintille o particelle di luce disperse, si ripresentano in primo piano in questa più tarda fase di sviluppo del pensiero cabbalistico. Indubbiamente in questo caso non si tratta di un legame storico tra il manicheismo e la nuova scuola di Safed, ma solo di una disposizione di animo affine che pertanto produsse risultati e idee affini. Tuttavia, e forse appunto perciò, uno studio più particolareggiato del sistema di Luria sarebbe di notevole interesse anche per lo studioso della gnosi: perché quel sistema – sia nel complesso che nei dettagli – può essere considerato come un caso esemplare di un modo di pensare tipicamente gnostico"30. In tal modo attraverso strade diverse la visione di Mani, quel suo unire indissolubilmente nichilismo e salvezza, disprezzo ed ascesi, abominio dei corpi e deificazione delle anime, continua ad essere presente nel sottofondo inquieto della cultura e della spiritualità moderna. Una presenza che anche oggi, in un orizzonte suggestionato dal Nulla e dal Caos, trapela nell’idea di un mondo in guerra, diviso tra le Forze del Bene e quelle del Male, tra i Puri e gli Impuri, tra la Luce e le Tenebre.