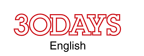L’apostolo dei sordomuti
San Filippo Smaldone dedicò tutta la sua vita ai sordomunti. Una missione che prosegue grazie alle Suore salesiane dei Sacri Cuori. In tutto il mondo. E in ginocchio
di Davide Malacaria
Un ordine religioso dedito
all’assistenza dei sordomuti, secondo i desideri di san Filippo
Smaldone, sacerdote napoletano vissuto nel secolo scorso (1848
–1923), quando questa menomazione era sinonimo di emarginazione. Non
solo sociale. I sordomuti, cui spesso si attribuiva demenza, erano
generalmente accomunati ai pagani in quanto ritenuti impossibilitati a
ricevere i rudimenti del catechismo. Una vocazione nata per caso, quella di
don Smaldone, dopo che ebbe assistito, in chiesa, al pianto sconsolato di
un bambino in braccio a sua madre, incapace di calmarlo. Una commozione che
il Signore trasforma in attiva carità. E che presto si propaga, ad
abbracciare una moltitudine di ammalati e, in particolare, i
“suoi” sordomuti. Un amore al Signore ardente, quello di don
Smaldone, che ha il suo cuore nell’adorazione eucaristica, tanto che
si ritrova a fondare la Lega eucaristica dei sacerdoti adoratori e,
successivamente, le Dame adoratrici. Ma il suo nome si associa alla nascita
di un ordine religioso femminile da lui intensamente desiderato: le Suore
salesiane dei Sacri Cuori. «Nessuno può dare quel che non
ha», spiega suor Ines De Giorgi, vicaria generale dell’Ordine:
«l’attenzione ai poveri, a chi non ha voce, non si può
concepire senza una grande sensibilità verso il fratello sofferente,
senza la visione chiara di un’umanità in cui il volto di
Cristo si rende visibile. L’itinerario di san Smaldone è un
viaggio di carità, di intelligente premura e di fiduciosa speranza,
che ora prosegue grazie a quelle suore che lui stesso volle creare a
sostegno della sua opera».
La Congregazione, con le sue scuole e i suoi convitti per sordomuti, è presente in tutta Italia, ma soprattutto al Sud, dove si è dipanata la vita e l’opera di don Smaldone. Opera che ancora adesso attrae tanti, in particolare giovani, che aiutano e sostengono. Di recente è nata Missione Effatà (www.missioneeffata.it), una onlus che ha «lo scopo di fornire a tali opere un supporto professionale e di favorire la raccolta dell’otto per mille», spiega Giancarlo Fedele che ne è stato il promotore.
Nel 1972 la Congregazione inizia la prima missione all’estero, in Brasile. Poche sorelle all’inizio, ma presto è un fiorire di istituti, di vocazioni, di opere, ad abbracciare le selve amazzoniche e le città più sviluppate e problematiche dello Stato.
È il 1987 quando le salesiane dei Sacri Cuori giungono in Africa. Qui, tra gli ultimi del mondo, i sordomuti, emarginati e poco attrezzati alla sopravvivenza quotidiana, rappresentano gli ultimi degli ultimi. In Ruanda, a prezzo di molte fatiche, nasce una presenza che attraversa, inerme, gli orrori del più terrificante genocidio africano. Oggi sono tre le comunità operanti nel piccolo Stato africano dove, accanto alla consueta assistenza ai bambini privi di udito, si sta sviluppando un itinerario postscolastico, con corsi di formazione, per aiutare i ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro. Sempre in Africa sono sorti istituti in Benin (2007) e più recentemente in Tanzania.
Apparentemente meno significativa la presenza nell’Europa dell’Est, precisamente in Moldavia, dove le salesiane dei Sacri Cuori collaborano con il Regina Pacis, un’istituzione voluta dall’arcivescovo di Lecce, monsignor Cosmo Ruppi, per seguire i ragazzi di strada. Qui le religiose, spiega una loro pubblicazione, sperimentano un nuovo orizzonte perché, «senza vincoli di natura strutturale e gestionale», sono chiamate a vivere la «radicalità evangelica». Una condizione nella quale, aggiungono, «s’impara, a piccoli passi, a scoprirci Chiesa itinerante, Chiesa povera, Chiesa in ginocchio, aperta ad accogliere e presentare il volto misericordioso di Dio».
Piace in particolare questa immagine di Chiesa in ginocchio. Da custodire.
La Congregazione, con le sue scuole e i suoi convitti per sordomuti, è presente in tutta Italia, ma soprattutto al Sud, dove si è dipanata la vita e l’opera di don Smaldone. Opera che ancora adesso attrae tanti, in particolare giovani, che aiutano e sostengono. Di recente è nata Missione Effatà (www.missioneeffata.it), una onlus che ha «lo scopo di fornire a tali opere un supporto professionale e di favorire la raccolta dell’otto per mille», spiega Giancarlo Fedele che ne è stato il promotore.
Nel 1972 la Congregazione inizia la prima missione all’estero, in Brasile. Poche sorelle all’inizio, ma presto è un fiorire di istituti, di vocazioni, di opere, ad abbracciare le selve amazzoniche e le città più sviluppate e problematiche dello Stato.
È il 1987 quando le salesiane dei Sacri Cuori giungono in Africa. Qui, tra gli ultimi del mondo, i sordomuti, emarginati e poco attrezzati alla sopravvivenza quotidiana, rappresentano gli ultimi degli ultimi. In Ruanda, a prezzo di molte fatiche, nasce una presenza che attraversa, inerme, gli orrori del più terrificante genocidio africano. Oggi sono tre le comunità operanti nel piccolo Stato africano dove, accanto alla consueta assistenza ai bambini privi di udito, si sta sviluppando un itinerario postscolastico, con corsi di formazione, per aiutare i ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro. Sempre in Africa sono sorti istituti in Benin (2007) e più recentemente in Tanzania.
Apparentemente meno significativa la presenza nell’Europa dell’Est, precisamente in Moldavia, dove le salesiane dei Sacri Cuori collaborano con il Regina Pacis, un’istituzione voluta dall’arcivescovo di Lecce, monsignor Cosmo Ruppi, per seguire i ragazzi di strada. Qui le religiose, spiega una loro pubblicazione, sperimentano un nuovo orizzonte perché, «senza vincoli di natura strutturale e gestionale», sono chiamate a vivere la «radicalità evangelica». Una condizione nella quale, aggiungono, «s’impara, a piccoli passi, a scoprirci Chiesa itinerante, Chiesa povera, Chiesa in ginocchio, aperta ad accogliere e presentare il volto misericordioso di Dio».
Piace in particolare questa immagine di Chiesa in ginocchio. Da custodire.