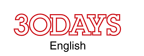Un libro e due stupori

J. Ratzinger-W. Congdon, Il sabato della storia, Milano, Ed. Fiua-Jaca Book, 1998
Meditare su questa falsariga è facile ed è motivo di rasserenamento dello spirito.
Giulio Andreotti
La scrittrice e l’Olocausto

Rosetta Loy, La parola ebreo, Torino, Einaudi, 1997
Pio XI fa una gran bella figura in questo racconto. Capace di far rimangiare all’arcivescovo di Vienna Innitzer le sue entusiastiche dichiarazioni in favore di Hitler, Pio XI è «un Papa non facile da intimidire; un vero uomo, un osso impossibile da masticare» (p. 62). È il Papa che con un’enciclica (cfr. sul numero del dicembre ’95 di 30Giorni alle pp. 61ss.) avrebbe espresso, se mai lo avesse potuto perché mai quell’enciclica vide la luce, la sua forte riprovazione contro il razzismo e l’antisemitismo. È il Papa che la morte colse proprio mentre preparava il discorso per il decimo anniversario dei Patti Lateranensi, che tanto Mussolini temeva per la denuncia di violazione del Concordato che vi sarebbe stata inclusa. Una morte provvidenziale, dunque, in ordine alla quale la Loy, benché lo neghi, lascia riaffiorare i sospetti.
Ci si chiede però subito perché Pio XII, il vero protagonista del libro, che si apre e si chiude parlando di lui, non sia associato all’opera del suo predecessore, perché anzi risulti tratteggiato più come un personaggio da romanzo, più come il cattivo di turno che come un personaggio storico. A Pio XII, di non negativo, si dovrebbe ascrivere il telegramma (cfr. p. 86) inviato a seguito dell’invasione di Belgio, Olanda e Lussemburgo. Nient’altro. In realtà anche nel caso specifico la storia documentale dice che fece molto di più: arrivò a comunicare segretamente in anticipo a Parigi e a Londra le modalità di quella avanzata, ma non trovò ascolto.
Quanto agli ebrei, secondo la Loy, «nulla smuove l’incrollabile silenzio di Pio XII» (p. 110). E la quarta di copertina, imputabile certo non all’autrice, ma che comunque dice l’intento editoriale, rincara la dose: «L’autrice [...] si insinua nelle pieghe dei fatti raccontando con l’aiuto di lettere, dichiarazioni, discorsi, i passaggi cruciali di un periodo in cui nessuno – tanto meno la diplomazia vaticana, soprattutto nella persona di Pio XII, – è stato capace di opporsi alla follia nazista». Ora, se anche non si vuole prestare fede alla testimonianza, risalente come fonte al cardinale Faulhaber, riguardo a una diretta partecipazione dell’allora segretario di Stato Pacelli alla stesura della Mit brennender Sorge (cfr., fra “I libri di 30Giorni”, Pro papa Pio di Quirino Paganuzzi, pp. 24-29), si dovrà accettare quanto monsignor Paganuzzi poté verificare di persona in una missione nella Polonia occupata, ovvero che lo stesso arcivescovo di Cracovia Adam Sapieha, che in un primo tempo aveva richiesto un esplicito pronunciamento di Roma, lo respinse poi per la paura di provocare guasti maggiori. Padre Pierre Blet conviene che il silenzio era l’unico modo di operare da parte del Papa (si veda la lunga intervista da lui concessa a 30Giorni dell’aprile 1998, pp. 46-51). Padre Blet è l’unico vivente dei quattro gesuiti cui fu affidato da Paolo VI l’incarico di raccogliere i documenti della Santa Sede relativi alla seconda guerra mondiale, raccolta che è confluita nei dodici volumi degli Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale e recentissimamente in un libro dello stesso padre Blet che ne opera una sintesi: Pie XII et la Seconde Guerre mondiale d’après les archives du Vatican. Non a caso di queste fonti non c’è traccia nell’opera della Loy. Che dunque rischia di cadere sotto la medesima critica cui nelle prime pagine sottopone, quasi ad ammonimento, la Storia di Cristo di Papini: «un romanzo a tesi» (p. 9). Anche de La parola ebreo si dovrebbe dire lo stesso: “un racconto a tesi”. La tesi essendo quella, inaugurata nel 1963 da Hochhuth (fatidico nome pieno di consonanti mute), sul silenzio di Pio XII. Tesi stagionale, che ritorna quasi a scadenze fisse. In realtà stagionata.
Ma per fortuna il libro non riesce del tutto a dimenticare la sua natura di poesia. E l’autrice descrive, come fosse la bambina di allora, colori, odori e sapori di quella stagione impareggiabile della vita, quando le parole e le cose si imprimono in noi in modo indelebile. Certo, la cattiva coscienza è sempre lì a finalizzare ogni incanto, ogni descrizione alla tesi. E purtuttavia qualcosa rimane. L’albero del pepe in mezzo alla polvere del cortile della scuola, gli occhi grigio-azzurri di papà da cui la capretta disubbidiente della favola «sembra spiccare il salto», e «i capelli grigi raccolti in una retina» della signora Della Seta, la vicina ebrea, la cui ultima gentilezza sarà di porgere un pesce a Rosetta e ai suoi fratelli che stanno traslocando. Non la rivedranno mai più. «La signora Della Seta in piedi regge un piatto di metallo su cui è adagiata una spigola lessa. Per noi ragazzi in questa giornata di confusione. Un pesce che non si sa con quanta fatica lei è riuscita a procurarsi e noi mangeremo nella nuova casa tra l’odore dei pini e il frinire delle cicale» (p. 107). Non è un caso che quella spigola lessa sia rimasta negli occhi di Rosetta e che a portarla fosse la signora Della Seta. ’Ixyúw. Scriveva don Giussani il 2 gennaio scorso su la Repubblica: «Gesù di Nazareth per noi è il compimento dell’attesa in cui tutto il popolo d’Israele è vissuto, unico nella storia del mondo. Ma la nostra non è presunzione, bensì uno stupefatto paragone, per cui a noi poveri uomini comuni il Mistero di quella persona si è comunicato, sì che guardando la storia come ha raggiunto noi in paragone con la storia degli ebrei, saremmo più felici di chiedere ai nostri fratelli ebrei di perdonarci la nostra certezza, mentre a essi è riservato ancora di portare pondus diei et aestus (cioè tutto il peso della storia) nella vita» (ripubblicato in 30Giorni del gennaio 1999, pp. 94-95).
Non è attraverso la cattiva coscienza che paghiamo il nostro debito di riconoscenza, ma attraverso uno stupefatto paragone.
Lorenzo Cappelletti