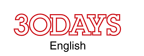Fede, ragione e istituzioni della Chiesa
del cardinale Joseph Ratzinger

Miniature tratte dall’evangelario dell’abbazia benedettina di Groß Sankt Martin, a Colonia, dell’inizio del XIII secolo, ora conservato nella Biblioteca Reale di Bruxelles. Gesù risorto con gli apostoli
1. Il cardinale dice che nella mia analisi della decisione fondamentale della Chiesa antica non solo avrei dovuto prendere in considerazione il rapporto tra fede e razionalità, ma anche mettere in evidenza la relazione tra fede e diritto romano. Non posso seguirlo su questo punto. La relazione, infatti, tra fede e ragione è un’opzione originaria della fede cristiana, già chiaramente formulata nella letteratura profetica e sapienziale dell’Antico Testamento e, successivamente, ripresa risolutamente dal Nuovo Testamento. La pretesa, in opposizione alla religione mitica e politica, di essere una fede in rapporto con la verità e per questo responsabile nei confronti della ragione, appartiene alla autodefinizione essenziale dell’eredità biblica, eredità che ha preceduto la missione e la teologia cristiane, che – ancora meglio – le ha rese possibili.
La relazione con il diritto romano, al contrario, è stata sviluppata progressivamente solo a partire dal IV secolo e in Occidente, a causa del disgregamento delle strutture dell’Impero, non ha mai potuto raggiungere la stessa importanza che ha avuto nella Chiesa imperiale bizantina. Si tratta di un’opzione secondaria intervenuta in un’epoca determinata e che potrebbe anche nuovamente venir meno. Che comunque diritto e Chiesa restino fondamentalmente in relazione reciproca è valido indipendentemente da questo.
2. Il mio confratello del collegio cardinalizio è convinto che io abbia sottovalutato il valore delle istituzioni. Non si può contestare il fatto che la fede cristiana fin dalle origini non ha voluto essere solo un’idea ma che è entrata nel mondo provvista di elementi istituzionali (ministero apostolico, successione apostolica) e che la forma istituzionale della Chiesa è quindi parte essenziale della fede. Ma le istituzioni possono vivere solo se sostenute da convinzioni fondamentali comuni e se esiste un’evidenza dei valori che fondano la loro identità.

Gesù risorto e Tommaso
Colui che difende la dottrina trinitaria, la cristologia, la struttura sacramentale della Chiesa, la sua origine in Cristo, il ministero petrino o l’insegnamento morale fondamentale della Chiesa, ecc. e che deve far passare il loro disconoscimento come incompatibile con l’istituzione Chiesa, colpisce a vuoto se si diffonde l’opinione che tutto ciò è senza importanza. È in questo modo che una istituzione diventa una carcassa vuota e va in rovina, anche se esteriormente resta potente o dà l’impressione di poggiare su solide fondamenta. È per questa ragione che le decisioni istituzionali del Magistero possono diventare feconde solo se si legano a una lotta seria, convinta, per una nuova evidenza delle opzioni portanti della fede.
3. Il cardinale Eyt attira l’attenzione sul fatto che la ragione evolve e non può irrigidirsi in una pretesa età dell’oro. In ciò il cardinale mi trova d’accordo senza riserve. Lungi da me voler limitare la “ragione” allo stato che essa aveva raggiunto all’epoca dei Padri della Chiesa. È essenziale che essa si interroghi sempre di nuovo e che ogni acquisizione diventi una nuova ricerca.
Nell’introduzione alla mia conferenza ho tentato di indicare brevemente alcune questioni che la teologia deve porsi oggi. Nel mio intervento ho dovuto limitarmi a una questione fondamentale, quella preliminare a tutte le altre: l’opzione per Dio, per un Dio che è Logos (Ragione) e Amore (ambedue inseparabili) può oggi, nel contesto delle nostre conoscenze, essere considerata ancora ragionevole? Ho tentato di indicare le ragioni a favore e sono lieto se altri lo fanno meglio di me.