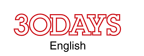VENT’ANNI DOPO. Dal crollo del Muro alla crisi globale
Successore del successore di Pietro
di Gianni Valente
![Marx durante un’ordinazione sacerdotale nel Duomo di Frisinga nel giugno 2009 [© Katharina Ebel/KNA-Bild]](/upload/articoli_immagini_interne/1257420619473.jpg)
Marx durante un’ordinazione sacerdotale nel Duomo di Frisinga nel giugno 2009 [© Katharina Ebel/KNA-Bild]
«Sono il successore del successore di Pietro!», scherza oggi Reinhard Marx. Ma la sua «critica cristiana alle ragioni del mercato» (così recita il sottotitolo della versione italiana del suo Das Kapital, pubblicata da Rizzoli la scorsa primavera) è piuttosto seria.
Secondo il vescovo, nell’ultimo ventennio, la globalizzazione liberista e l’usurocrazia degli speculatori hanno inferto colpi esiziali proprio a quell’economia sociale di mercato che coi suoi elementi di tutela e di correzione – salari minimi garantiti coi contratti collettivi, welfare robusto e diffuso, ammortizzatori sociali per i disoccupati e le fasce deboli – sembrava aver smentito le profezie marxiane sull’inevitabile testacoda del modello di sviluppo economico capitalista. Così, dopo il tramonto storico del comunismo, proprio i processi di concentrazione smisurata della ricchezza, il senso diffuso d’alienazione prodotto dalla generale precarizzazione del lavoro, l’emergere di nuove oligarchie finanziarie e la progressiva erosione dei ceti medi offrono al filosofo di Treviri la chance di una postuma, paradossale rivincita. «Poggiamo tutti sulle spalle di Marx. Nella sua analisi del XIX secolo ci sono punti inconfutabili», ha riconosciuto il vescovo in un’intervista a Der Spiegel poco più di un anno fa.
Nel suo libro, Reinhard Marx descrive con passione pastorale e concretezza non moraleggiante gli effetti destabilizzanti prodotti dall’accelerazione “turbocapitalistica” nel vissuto concreto di ampia parte della popolazione mondiale: eclissi delle tutele ottenute dalle lotte sindacali, erosione del valore reale dei salari, graduale scomparsa del commercio al dettaglio, allargamento surreale della forbice che separa un’élite di super-ricchi («Se alla fine degli anni Settanta un manager americano guadagnava in media venticinque volte il salario di un operaio, appena trent’anni dopo è salito a cinquecento») e masse di ex appartenenti al ceto medio divenuti inesorabilmente working poors, persone che «pur disponendo di un lavoro fisso, vivono al di sotto della soglia di povertà». La radice di questi processi è per l’appunto descrivibile in termini marxiani.«Nell’ambito dell’antico conflitto tra lavoro e capitale», riconosce l’arcivescovo di Monaco e Frisinga, citando il sociologo Manuel Castells, «l’incremento della velocità nello scambio di informazioni, beni e spesso anche servizi ha spostato i pesi a favore del capitale […]. Il capitale è nella sostanza globale, il lavoro è di regola locale. In questo modo le possibilità di investitori, speculatori e prestigiatori della finanza aumentano, mentre coloro che possono contare solo sull’operosità delle proprie mani hanno la peggio».
Davanti a un tale stato di cose, c’è chi ha già riservato alla Chiesa il ruolo di sparring partner, garante della natura “compassionevole” del neocapitalismo: «Nonostante tutte le critiche rivolte alla Chiesa», scrive il vescovo Reinhard, ironizzando sull’artificiosità ideologica dell’operazione, «da lei ci si attende comunque il “riarmo morale”, in mancanza di altre istituzioni. Come se si potesse sfornare morale così come si sfornano panini. O come se la morale fosse l’essenza del cristianesimo, come se Gesù avesse soprattutto pensato a cementare la nostra società con la morale. Non riesco proprio a trovare conferma, scorrendo le pagine del Vangelo, che questa sia stata la sua preoccupazione primaria».