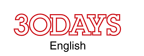Sudan tra guerra e pace
Dopo oltre vent’anni di conflitti il Nord e il Sud del Paese hanno firmato un accordo di pace. Un passo importante che rischia di essere vanificato dal conflitto in Darfur
di Davide Malacaria

Profughi del Darfur in Ciad
In breve: il 9 gennaio, a Nairobi, in Kenya, il leader dei ribelli dello Spla (Esercito popolare di liberazione del Sudan), John Garang, e il viceministro di Karthoum, Ali Osman Taha, hanno firmato un accordo che mette fine a un conflitto che, dal 1983 ad oggi, ha causato circa due milioni di morti e quattro milioni e 600mila profughi. Un accordo a lungo inseguito dalla comunità internazionale, in particolare dall’Onu e dall’Unione africana che, dopo anni di pressioni, hanno costretto le parti a sedersi attorno a un tavolo e a giungere a un compromesso. In sostanza gli accordi di Nairobi sanciscono la spartizione del Sudan in due diverse aree geopolitiche, Nord e Sud, che avranno due governi diversi, due eserciti diversi, ma rimarranno parte di una stessa nazione. Questo per un periodo di transizione di sei anni, trascorsi i quali il Sud dovrà decidere se staccarsi o meno dal Nord. Ma il punto cruciale sul quale c’è stata la vera battaglia sono le royalty sui proventi del petrolio, del quale è ricco il sottosuolo del Sud, che sono state spartite al cinquanta per cento tra Nord e Sud. Uno spiraglio di speranza che però non deve illudere. La pace deve ancora mettere le sue radici nel Paese, sia perché l’accordo deve reggere ai rovesci dei fragili equilibri geopolitici africani, sia perché nell’ovest del Paese, nella zona del Darfur, si è acceso un conflitto più recente di quello tra Nord e Sud, ma non meno sanguinoso, in un crescendo di tensione che rende ancor più precario il compromesso raggiunto a Nairobi. Una precarietà che non sfugge a coloro che hanno visto da vicino gli orrori di questa guerra, i quali, proprio per questo, guardano alla riconciliazione tra Nord e Sud con un misto di sollievo e prudenza.
«Già altre volte il Nord e il Sud hanno intavolato trattative, raggiunto accordi… però questa volta sembra diverso», spiega padre Fernando Colombo, comboniano, da 25 anni in Africa e da tre affidato alla diocesi di Rumbek, nel cuore del Sud Sudan, in ausilio al vescovo locale: «La popolazione ha accolto gli accordi tra Nord e Sud con grande gioia e grande speranza. Certo bisogna vedere se saranno rispettati. Però il fatto nuovo è che la comunità internazionale sembra seriamente intenzionata a portare avanti il processo di pace: una novità che lascia sperare e dà una certa garanzia». Anche padre Renato Kizito Sesana ha accolto con sollievo la firma dell’accordo di pace. Padre Kizito, anche lui comboniano, è un profondo conoscitore del Sudan: per anni, durante la guerra, si è introdotto in quello Stato per raggiungere le popolazioni locali, a volte in maniera rocambolesca, essendo persona poco gradita sia al governo del Nord che al capo dei ribelli del Sud. Di questi viaggi e degli inaspettati incontri con la gente sudanese ha redatto un resoconto in un bellissimo libro (vedi box). Al telefono non nasconde le sue perplessità: «Purtroppo questo accordo presenta diversi lati oscuri: è ponderoso, appesantito da una serie di clausole che lo rendono farraginoso e di difficile applicazione. Né si capisce bene come la comunità internazionale riuscirà a vigilare sul rispetto di tutte queste clausole. Insomma la struttura stessa dell’accordo indica che la pace è stata imposta dall’esterno, più che voluta da chi l’ha firmato. Certo si è accordata la libertà di religione, ma non è previsto un processo di democratizzazione interno, né al Nord né al Sud. Infatti se al Nord vige un regime autoritario, è vero anche che, al Sud, John Garang ha schiacciato ogni dissenso interno e sono stati marginalizzati gli altri movimenti di liberazione non organici ai suoi disegni». Insomma, gli accordi di Nairobi sono forse un punto di partenza più che di arrivo, ma in ogni caso è un inizio. Un buon inizio.
Una guerra lunga
oltre venti anni
Un luogo comune, rimbalzato tra analisti, osservatori internazionali e mass media, ha voluto dipingere il conflitto tra il Nord e il Sud Sudan come una guerra tra il Nord arabo e musulmano e il Sud animista e cristiano. Una definizione che però non fotografa una realtà che appare ben più complessa e articolata. Spiega padre Kizito: «In Sudan non c’è stata una guerra di religione: basti pensare che all’inizio del conflitto, ventidue anni fa, i movimenti di liberazione del Sud erano d’ispirazione marxista-leninista. Le cose iniziano a cambiare verso la metà degli anniNovanta, quando la destra americana scopre l’esistenza del Sudan e la guerriglia è pronta a sfruttare questa occasione, riuscendo ad accreditarsi come movimento cristiano per ottenere aiuti politici ed economici. Un errore in cui è caduto, in buona fede, anche qualche ecclesiastico del Sud. Questa confusione ha comportato, a volte, un difetto nel denunciare gli abusi della guerriglia nei confronti della popolazione del Sud, ma soprattutto ha favorito l’accreditarsi della guerriglia come un movimento cristiano. Ci sono alcuni documenti dello Spla in cui si propone addirittura di definire la Chiesa come “ala spirituale” del movimento… tutte cose che era meglio evitare. Certo, le differenze religiose sono state parte del conflitto, ma parlare di guerra di religione è fuorviante. In realtà si è trattato di una guerra per i diritti dei popoli del Sud».
D’altronde, per capire che non si è trattato di una guerra di religione basta vedere quanto è avvenuto sui monti Nuba, laddove la repressione militare ha particolarmente infierito contro la popolazione civile e la resistenza armata, in una guerra santa che ha messo sullo stesso piano cristiani e musulmani. Stefano Squarcina, segretario aggiunto dell’Unione europea per i rapporti con il Terzo mondo, di recente in Sudan per conto dell’Ue, traccia un profilo geopolitico molto interessante: «In realtà molti osservatori internazionali concordano che ci sia un disegno per mettere sotto pressione il governo sudanese. Certo è innegabile che questo governo sia autoritario. Come è innegabile che in Sudan abbia trovato sostegno il terrorismo internazionale. Basti pensare che Osama Bin Laden per anni ha trovato rifugio proprio qui. Una situazione che non poteva essere ignorata. E, come avvenuto per l’Iraq, anche nei confronti del Sudan si confrontano due linee di pensiero: quella diplomatica e quella dura; per semplificare diciamo quella dialogante dell’Unione europea e quella dei falchi Usa. In questi ultimi ambienti sembra che si coltivi l’idea di smembrare lo Stato attuale in tre aree più omogenee e quindi più controllabili: il Nord, il Sud e l’Est. In questo senso va letto anche il favore con cui certi ambienti statunitensi guardano ai movimenti guerriglieri del Sud e dell’Est, dove sono presenti altri movimenti di liberazione (il “Free lion movement” e il “Beja congress”), in particolare negli Stati del Kassala e Gedaref. Ma bisogna stare attenti: destabilizzare il Sudan è molto pericoloso, rischia di saltare tutta l’area. Né si può escludere a priori un dialogo con il regime sudanese che, come tutti i regimi, è una sintesi di realtà diverse e, accanto ai duri, ci sono persone ragionevoli con le quali si può trovare un dialogo». Quest’ultima affermazione di Squarcina trova conferma in quanto avvenuto a Nairobi.

Sopra, la firma degli accordi di pace tra Nord e Sud Sudan a Nairobi;
Dopo il Sud, il Darfur
Al di là delle analisi geopolitiche, al Sud gli scontri tra esercito e guerriglieri, per ora, sono un ricordo del passato. Una bella notizia per le martoriate popolazioni locali, costrette da anni, ogni giorno, a tentare di sfuggire ai bombardamenti delle forze governative e alle angherie dei ribelli (tra l’altro, lo Spla arruolava con la forza bambini-soldato). E, come racconta padre Colombo, a Rumbek, che sarà la futura capitale del Sud, sta lentamente ritornando un’embrionale attività commerciale. E si aspetta con una certa ansietà il ritorno dei profughi, milioni di persone che la guerra ha sparpagliato tra il resto del Paese e dell’Africa. Padre Colombo si dice preoccupato: molti di loro, spiega, hanno vissuto per anni in zone dove il virus dell’Aids è molto diffuso e teme che presto in Sud Sudan si verifichi una vera emergenza Aids. Nell’immediato, spiega, il problema sarà quello di trasformare una classe dirigente abituata alle armi in una classe politica vera e propria. E, soprattutto, di scongiurare disordini tra le varie fazioni del Sud pacificato. Anche monsignor Antonio Menegazzo, amministratore apostolico di El Obeid, ha questa preoccupazione: «La pace è stata siglata dai capi, ma tra la popolazione civile ci sono ancora odi, rancori, divisioni. Abbiamo paura che scoppino dei disordini. La Chiesa si sta adoperando per portare la calma, per riconciliare, ma il pericolo c’è». Tra l’altro, questo è il momento di decidere chi governerà nel Sud Sudan. John Garang, in base agli accordi, tra un anno volerà a Karthoum, dove diventerà vicepresidente del Paese. Molti temono che al Sud si possa aprire uno scontro per chi dovrà gestire il governo locale.

Profughi del Darfur in Ciad
La situazione del Darfur ora è sotto i riflettori dell’Onu. Ai primi di gennaio si è concluso il lavoro di una commissione incaricata di monitorare la situazione nella regione. Ne è uscito fuori un documento che rende conto delle tante atrocità commesse durante il conflitto. Un atto di accusa che ha fatto il giro del mondo prima ancora di essere reso pubblico. C’era chi si aspettava che la commissione dimostrasse che in Darfur è in atto un genocidio a opera del governo di Karthoum, accusa che avrebbe comportato un’azione immediata contro questo regime. Ma non è andata così: gli inviati dell’Onu hanno indicato i responsabili delle tante efferatezze accertate, senza coinvolgere in toto il governo. Ora il documento è al vaglio delle Nazioni Unite, dove si stanno cercando altre strade di pressione e d’intervento. Nel frattempo, in Darfur si continuerà a morire. A meno che quel momento di ragionevolezza e di realismo che ha portato agli accordi di Nairobi, alla fine, riesca ad imporsi sul fragore delle armi.