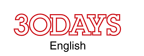La letteratura vista da vicino
A dieci anni da Giacomino, Antonio Debenedetti riprende in mano il filo dei propri ricordi e con Un piccolo grande Novecento racconta gli scrittori italiani che ha conosciuto. Sorprendendoli nei particolari e nei gesti più semplici e quotidiani, che sono importantissimi per capire la grandezza di quei personaggi e che sempre sfuggono alle grandi storie della letteratura. Intervista
intervista con Antonio Debenedetti di Paolo Mattei

Antonio De Benedetti
Oggi Debenedetti ha ripreso nuovamente a intessere i fili di tali ricordi, e con Un piccolo grande Novecento ha reso pubblico un altro brano di quella trama. Si tratta di un libro-intervista, in cui lo scrittore, conversando con Paolo Di Paolo, offre testimonianze dirette e indirette sui protagonisti della letteratura e dell’arte di quel “piccolo grande” secolo. Un album in cui, attraverso le parole di Debenedetti, troviamo, sorpresi in un gesto magari banale eppure capace di dire moltissime cose, romanzieri e poeti come Gadda, Moravia, Caproni, Pasolini, Montale, Ungaretti, Saba, accanto a decine di altri personaggi, registi, giornalisti, critici e pittori. Parafrasandone un passaggio in cui si accenna ad Auden, di questo libro si può dire che «al posto del monumento che edificano le storie letterarie, abbiamo davanti le fotografie di quanto il tempo, l’intelligenza, il dolore e la fuga dal dolore hanno fatto del poeta».
«Questo modo di raccontare la letteratura come una cosa vista da vicino è inusuale in Italia e se ne sente la mancanza», spiega Debenedetti a 30Giorni. «Da noi sono assenti le pubblicazioni diaristiche, molto diffuse per esempio in Francia. Penso al journal dei fratelli De Goncourt, a quello di André Gide o di Jules Renard, in cui “mostri sacri” della letteratura sono lì che ci parlano attraverso particolari semplici e molto umani. Questo passato “mitico” diventa vicino e quindi più comprensibile». A Debenedetti l’idea di mettere di nuovo a disposizione dei lettori i propri ricordi è venuta durante il periodo in cui ha indossato i panni del docente universitario a Roma Tre. «Mi sono reso conto che partendo dalla descrizione della realtà quotidiana in cui gli scrittori si muovevano e si muovono, ed evitando di presentare questi uomini come degli dei – perché, naturalmente, non lo sono affatto –, sollecitavo più vigorosamente l’interesse dei ragazzi. Spiegavo loro le idee degli artisti non mediante astrazioni, ma attraverso il ricordo vivo che io ho di essi. D’altronde, le grandi idee spesso si dicono anche a tavola, si spiegano agli amici nelle occasioni più normali. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere Moravia, Caproni, Saba, Ungaretti, Bassani... O di sentir narrare vicende di scrittori e poeti del Novecento dalla viva voce di altri poeti e scrittori che ho incrociato nella mia vita. Ho, quindi, in un certo senso, un debito verso la società. E lo assolvo raccontando...». Il professor Debenedetti sa senz’altro che la memoria può essere uno specchio deformante. «Sì, ma è una deformazione molto umana, provocata dal cuore di chi ricorda. I libri di storia della letteratura devono escludere il sentimento e il cuore, mentre chi scrive i propri ricordi, il cuore lo mette in gioco completamente. Proprio per questo penso di aver esercitato un’efficace operazione maieutica durante l’unico anno della mia vita in cui ho insegnato all’Università, visto che con molti studenti mantengo tuttora i contatti. Spero che questo libro produca gli stessi buoni effetti di tale esperienza di insegnamento».

Foto di gruppo al Caffè Greco di Roma nel 1947
Oltre al Sessantotto, Debenedetti individua un altro anno che considera esiziale per la cultura e la società italiane: il 1993. «Fu l’anno della morte di Fellini, l’anno, cioè, della morte dell’ultimo dei maestri. L’ultimo dei padri. Nessuno è oggi in grado di raccontare l’Italia contemporanea come fece lui ai suoi tempi. Tre anni prima se n’era andato Moravia. Con loro finiva l’età dell’attesa, quando si potevano alzare gli occhi e guardare un cielo che sappiamo abitato dal vero talento e dal vero successo. Oggi nella nostra cultura sono assenti figure di quel calibro. La mia è una generazione di orfani incapaci di diventare padri». Quando gli si fa notare che il numero dei laudatores temporis acti va sempre di più crescendo e anche quello di chi proclama la morte della letteratura, Debenedetti abbandona il velo di malinconia. È sicuro che ci sono ragazzi che scrivono, «e ce ne sono di bravissimi. Guardi là: c’è un dattiloscritto di uno di quegli studenti che mi vengono a trovare. Il suo italiano è nel solco della nostra grande tradizione letteraria. Bisogna avere la pazienza di ascoltarli e di leggere le cose che scrivono».
E magari anche la capacità di raccontargli una “piccola grande” storia senza annoiarli o scoraggiarli. Come solo i padri sanno fare.